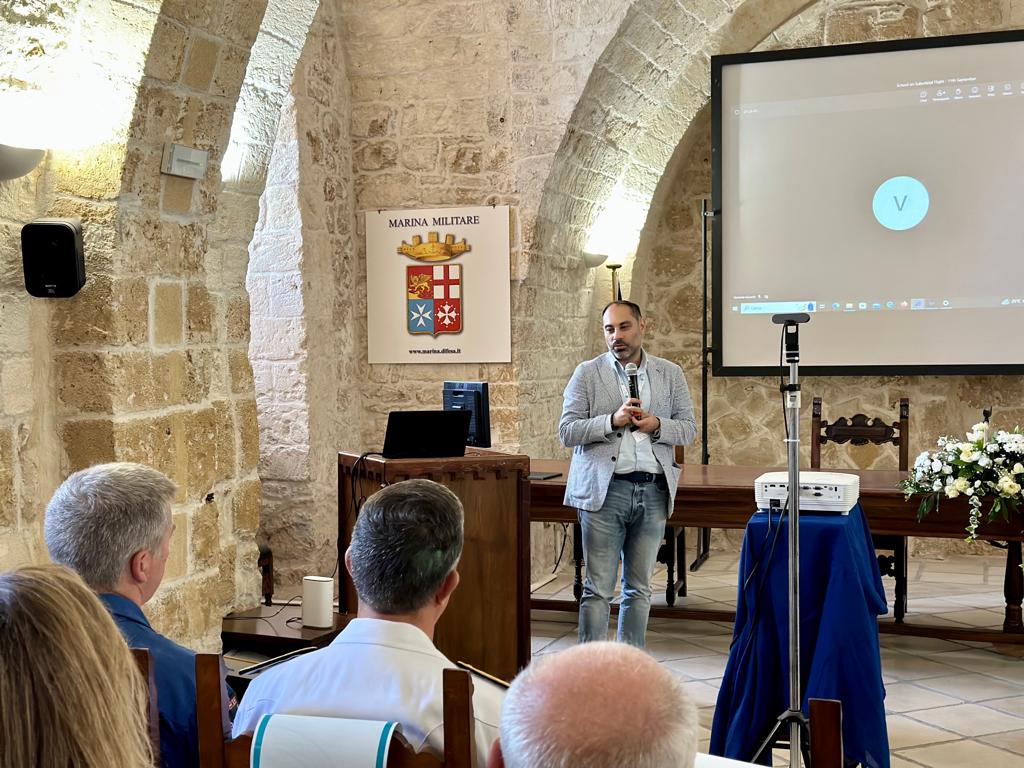Nel silenzio siderale dello spazio, dove la temperatura può scendere fino a circa -270°C, l’estremo freddo non è solo una sfida da affrontare, ma anche una risorsa da sfruttare. È in questo scenario che entra in gioco la tecnologia criogenica, diventata uno degli elementi strategici più rilevanti per le missioni spaziali del presente e soprattutto del futuro.
Dalla propulsione avanzata alla conservazione dei carburanti, dal raffreddamento dei sistemi elettronici alla gestione termica dei payload, la cryogenic si candida a essere uno snodo cruciale per abilitare la permanenza prolungata nello spazio profondo e per realizzare le nuove ambizioni dell’esplorazione umana e robotica.
La criogenia è la scienza che studia i fenomeni fisici e i processi tecnologici a temperature estremamente basse. In ambito spaziale, il termine viene comunemente associato alla gestione di fluidi superfreddi, come l’idrogeno liquido (LH2) e l’ossigeno liquido (LOX), utilizzati nei motori a razzo ad alta efficienza.
Ma la criogenia non si limita alla fase di lancio: diventa fondamentale anche nella gestione delle risorse durante le missioni di lunga durata, nell’alimentazione dei sistemi energetici e nella conservazione di materiali biologici, campioni geologici e strumenti scientifici.
Uno dei principali ambiti di applicazione è rappresentato dalla propulsione criogenica, già utilizzata con successo nei lanciatori di grandi dimensioni. I motori criogenici, grazie alla combinazione LH2/LOX, garantiscono un impulso specifico superiore rispetto ad altri sistemi convenzionali.
Questo significa più spinta a parità di massa, un vantaggio decisivo quando si tratta di portare carichi pesanti in orbita o oltre.
Tuttavia, l’utilizzo di propellenti criogenici comporta sfide tecniche notevoli: servono serbatoi isolati termicamente, valvole ultra-resistenti, sistemi di pressurizzazione sofisticati e, soprattutto, tecnologie in grado di mantenere i fluidi allo stato liquido anche in condizioni di microgravità e durante lunghi periodi di stoccaggio. È qui che si sta giocando una delle partite più importanti per le future missioni verso la Luna, Marte e oltre.
Nel contesto delle missioni interplanetarie, una delle grandi sfide è immagazzinare e trasferire propellenti criogenici nello spazio, senza perdita di massa e senza compromettere la sicurezza.
Diverse agenzie spaziali, tra cui NASA ed ESA, stanno sviluppando tecnologie di “in-space cryogenic fluid management” per consentire il rifornimento in orbita, l’accumulo di carburanti su stazioni spaziali o piattaforme lunari e la realizzazione di infrastrutture orbitali autonome per la logistica spaziale.
Nel 2023, la NASA ha lanciato con successo la missione Cryogenic Fluid Management (CFM), dimostrando per la prima volta la capacità di conservare idrogeno liquido in orbita per oltre 30 giorni. Un risultato che apre scenari nuovi per la sostenibilità e l’efficienza delle missioni future.
Ma la criogenia non è solo carburante. I sistemi elettronici avanzati, come i sensori di precisione, i rivelatori quantistici o i telescopi spaziali, richiedono ambienti termicamente controllati per funzionare correttamente. Il caso emblematico è quello del James Webb Space Telescope, che utilizza uno scudo solare e un sistema criogenico per mantenere i suoi strumenti a meno di -230°C, garantendo così l’osservazione dell’universo primordiale con una sensibilità senza precedenti.
Allo stesso modo, i futuri strumenti di navigazione quantistica, i payload scientifici per l’analisi molecolare e le tecnologie biologiche necessarie all’esplorazione umana dovranno operare in condizioni di temperatura ultra-stabile, grazie a moduli criogenici dedicati.
Anche l’Italia si sta muovendo con determinazione in questo ambito. Il CIRA (Centro Italiano Ricerche Aerospaziali) è impegnato da anni nello sviluppo di tecnologie termiche avanzate, inclusi sistemi di isolamento criogenico. Il centro collabora con ESA e con partner industriali per la qualificazione di materiali in grado di operare in ambienti estremi, come i serbatoi di prossima generazione e i pannelli a isolamento attivo.
Inoltre, l’industria italiana partecipa a progetti ESA come FLPP (Future Launchers Preparatory Programme), che include lo studio e la validazione di componenti criogenici avanzati. Alcune PMI, anche del Nord Est, stanno lavorando su valvole criogeniche intelligenti e micro-scambiatori termici, con possibili applicazioni sia in orbita bassa che in scenari lunari.
La cryogenic technology rappresenta anche una leva per l’economia circolare dello spazio. Pensiamo ai sistemi per riciclare fluidi a bordo di habitat orbitali, ai moduli di stoccaggio per l’energia prodotta da pannelli solari o da celle a combustibile, fino alla crioconservazione di campioni biologici e materiali genetici destinati a missioni di colonizzazione.
Le future stazioni spaziali commerciali dovranno integrare moduli criogenici multifunzione, e le basi lunari potranno utilizzare il freddo naturale del suolo per abbattere i costi energetici della conservazione.
La corsa allo spazio non si vince solo con la potenza, si vince anche con il controllo del freddo. In un contesto dove ogni grammo e ogni grado contano, la tecnologia criogenica si impone come abilitatore chiave per il nuovo paradigma spaziale. Investire in criogenia oggi significa costruire la capacità di restare, operare e innovare nello spazio di domani.
Giornalista, specializzata in Economia dello Spazio, in Economia del Mare e in Mindfulness - istruttrice MBSR e facilitatrice LEGO® SERIOUS PLAY® .Dal 2004 si occupa di Aerospazio e dal 2011 di Economia del Mare. Dirige Economia dello Spazio Magazine, Economia del Mare Magazine e Space& Blue Magazine, oltre a seguire le relazioni istituzionali ed esterne in questi settori per importanti stakeholder. Ideatrice del Progetto "Space&Blue Made in Italy" con il suo Forum Space&Blue e del Progetto "Blue Forum Italia network".