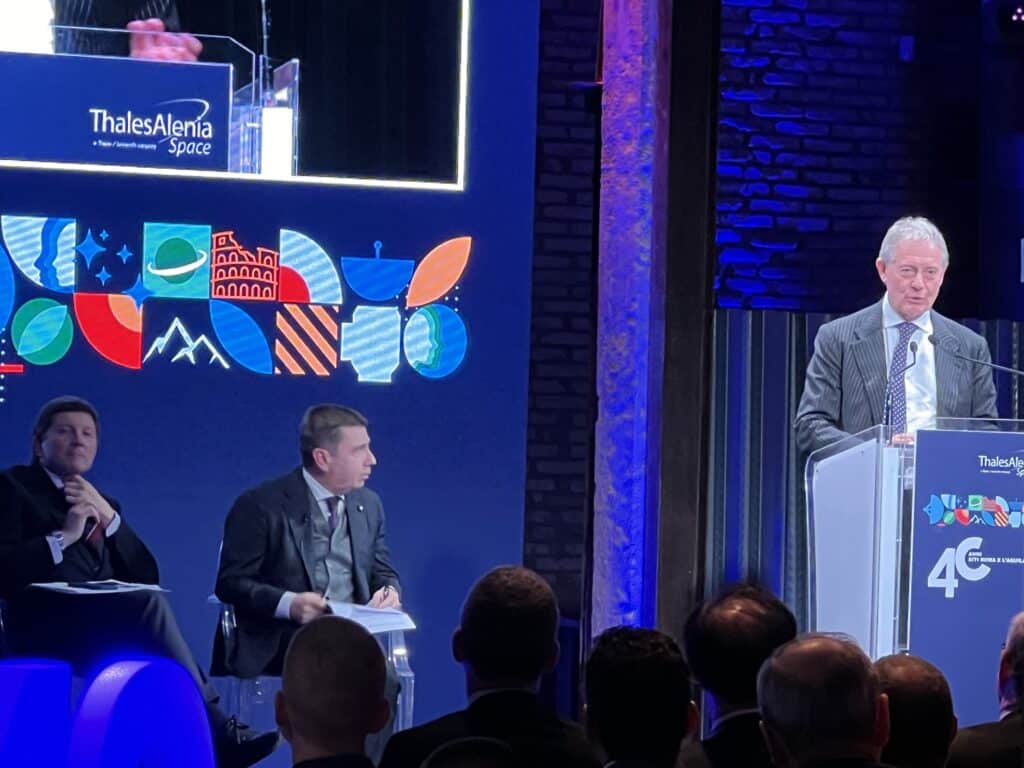L’orbita terrestre è sempre più affollata. Non si tratta più di una previsione a lungo termine, ma di un dato di fatto che oggi condiziona la sicurezza delle missioni spaziali e la sostenibilità economica del settore. A dirlo con chiarezza è l’ESA Space Environment Report 2024, che fotografa una situazione in rapido deterioramento. La gestione del ciclo di vita dei satelliti e la rimozione attiva dei detriti orbitali emergono come sfide centrali per i prossimi anni, destinate a influenzare tanto le scelte tecnologiche quanto quelle politiche.
Secondo i dati ESA, sono circa 35.000 gli oggetti di grandi dimensioni oggi monitorati in orbita terrestre. Di questi, soltanto 9.100 sono satelliti attivi, mentre il resto è costituito da satelliti non operativi e frammenti di missioni passate. A questi numeri si aggiungono oltre un milione di oggetti superiori a un centimetro, abbastanza grandi da causare danni gravi in caso di collisione, e più di 130 milioni di particelle comprese tra un millimetro e un centimetro, capaci di compromettere componenti sensibili.
Il 2024 ha registrato undici eventi di frammentazione non collisionali, che hanno generato almeno 2.600 nuovi detriti catalogati. Sono incidenti spesso dovuti a esplosioni di serbatoi con residui di carburante o cedimenti strutturali, che alimentano la spirale del rischio orbitale. Il ritmo dei rientri atmosferici spontanei, pur essendo elevato – più di tre al giorno in media – non compensa la crescita dei detriti in orbite medio-alte, dove gli oggetti restano per decenni.
La situazione delineata dall’ESA è chiara: la densità crescente di oggetti nello spazio aumenta la probabilità di collisioni. Il timore non è teorico, ma prende il nome di sindrome di Kessler, una reazione a catena in cui ogni collisione genera nuovi frammenti, che a loro volta alimentano ulteriori incidenti. Un simile scenario metterebbe a repentaglio non solo i satelliti commerciali, ma anche le infrastrutture critiche globali che dipendono da loro: telecomunicazioni, navigazione, monitoraggio climatico, osservazione della Terra e difesa. In altre parole, la space economy, che oggi vale miliardi di euro e coinvolge centinaia di attori, rischia di trovarsi ostaggio del proprio stesso successo.
Per affrontare il problema servono strategie parallele come progettare satelliti con sistemi di fine vita integrati e sperimentare la rimozione attiva dei detriti. Le soluzioni allo studio comprendono sistemi di deorbiting controllato, vele di frenaggio atmosferico, orbite cimitero, e missioni capaci di catturare oggetti grandi attraverso bracci robotici, reti, arpioni o tecniche senza contatto basate su laser e propulsione mirata. In parallelo, prende forma il concetto di manutenzione in orbita, con rifornimenti e aggiornamenti tecnologici che possono allungare la vita dei satelliti e ridurre la necessità di nuovi lanci.
La missione ClearSpace-1 rappresenta un passo simbolico e concreto in questa direzione. L’Agenzia Spaziale Europea, insieme a partner industriali, punta a dimostrare per la prima volta la capacità di catturare e deorbitare un detrito non cooperativo: un vecchio payload di circa 95 chilogrammi, con dimensioni di 60x60x80 centimetri. L’oggetto sarà afferrato grazie a quattro bracci robotici e guidato verso un rientro controllato nell’atmosfera, dove si disintegrerà in sicurezza. Il lancio della missione è previsto nel 2029 e segnerà l’avvio di una nuova generazione di operazioni spaziali dedicate alla pulizia orbitale.
La dimensione tecnologica, tuttavia, non basta. L’attuale quadro giuridico, fondato sul Trattato sullo Spazio Extra-atmosferico del 1967, non contiene norme vincolanti sulla gestione dei detriti. La responsabilità resta agli Stati che hanno registrato il lancio, ma la complessità crescente richiede regole condivise. A livello europeo, ESA e Commissione stanno lavorando per introdurre standard più stringenti, come l’obbligo di deorbiting entro cinque anni dal termine della missione. È un passo avanti, ma il vero salto sarà possibile solo con una cornice internazionale capace di armonizzare legislazioni diverse e creare incentivi economici e sanzioni efficaci.
La sostenibilità orbitale, a questo punto, non è un vincolo ma un’opportunità. Garantisce la sicurezza delle missioni, abbassa i costi assicurativi, favorisce la nascita di nuove filiere tecnologiche e accresce la credibilità degli attori che investono nello spazio. Proprio come i mari hanno imposto regole di navigazione e strumenti di salvaguardia, anche lo spazio deve dotarsi di una governance adeguata.
Il messaggio del Rapporto ESA 2024 è inequivocabile: senza un impegno strutturato nella gestione dei detriti orbitali, la crescita del settore rischia di incepparsi. Nei prossimi anni sarà decisivo consolidare nuove tecnologie, regole internazionali vincolanti e cooperazione istituzionale. La rimozione attiva e la gestione responsabile del ciclo di vita dei satelliti non sono più opzioni, ma imperativi politici ed economici. Solo così lo spazio potrà rimanere un ambiente accessibile, sicuro e fertile per l’innovazione del futuro.
Giornalista, specializzata in Economia dello Spazio, in Economia del Mare e in Mindfulness - istruttrice MBSR e facilitatrice LEGO® SERIOUS PLAY® .Dal 2004 si occupa di Aerospazio e dal 2011 di Economia del Mare. Dirige Economia dello Spazio Magazine, Economia del Mare Magazine e Space& Blue Magazine, oltre a seguire le relazioni istituzionali ed esterne in questi settori per importanti stakeholder. Ideatrice del Progetto "Space&Blue Made in Italy" con il suo Forum Space&Blue e del Progetto "Blue Forum Italia network".